Nella nostra traduzione da Substack.com. Bellissimo oltre che interessante. C'è da dire qualcosa di più sulla Vetus Latina [vedi]. Qui l'indice degli articoli sul Latino.
La lingua della cristianità occidentale
Con approfondimenti del Dott. Geoffrey Hull sul “latino facile e accessibile” del Medioevo
JACK CADE
Hai corrotto in modo molto traditore la gioventù del regno
fondando una scuola di grammatica... Ti sarà dimostrato
in faccia che hai intorno a te uomini che di solito
parlano di un sostantivo e di un verbo e di
parole abominevoli che nessun orecchio cristiano può sopportar di sentire...
LORD SAYE Voi uomini del Kent—
DICK IL MACELLAIO Che ne dici del Kent?
LORD SAYE Nient'altro che questo: 'bona terra, mala gens'
JACK CADE Toglietelo mezzo, toglietelo di mezzo! Parla latino.
Solo Shakespeare poteva integrare con tanta abilità una finta condanna sia della grammatica che del latino in un'opera teatrale sulle lotte di potere in Inghilterra nel tardo medioevo. Questo scambio di battute è tratto dall'Atto 4, scena 7 del Secondo Enrico VI, quando Jack Cade, il guastafeste, è a Londra a guidare una breve rivolta popolare. La sua osservazione su "sostantivo" e "verbo" come "parole così abominevoli che nessun orecchio cristiano può sopportare" è, per quanto riguarda il mio senso dell'umorismo, una vera e propria mina vagante. Inoltre, il disprezzo sfacciato di Cade per la grammatica e il latino è pieno di ironia, poiché queste furono le materie che costituirono il nucleo della formazione di Shakespeare e lo prepararono a diventare il più famoso drammaturgo, e uno dei più grandi poeti, della storia.
È difficile dire esattamente come Shakespeare considerasse il suo lavoro al liceo. Immagino che ne riconoscesse l'immenso valore nel trasformare la sua mente, ma nutrisse anche qualche dubbio sullo straordinario rigore del programma di studi:
Gli alunni maschi, di età compresa tra gli otto e i quindici anni circa, erano sottoposti ad un'ardua routine. Le lezioni iniziavano presto la mattina: normalmente alle sei; gli orari erano lunghi, le vacanze rare. L'istruzione era incentrata sul latino; nelle classi superiori, parlare inglese era proibito... Dalla grammatica, i ragazzi passavano allo studio di opere di letteratura classica e neoclassica. Potevano leggere antologie di detti latini e favole di Esopo, seguite dalle opere teatrali piuttosto facili [non le definirei "piuttosto facili"!] di Terenzio e Plauto... Potevano persino recitare scene di opere teatrali latine. Man mano che progredivano, miglioravano la loro padronanza della lingua traducendo dal latino all'inglese e viceversa... Mettendo in pratica quanto appreso, componevano epistole, orazioni e declamazioni formali.1
Oh, come sono cambiati i tempi! La mente si blocca in una confusione totale quando si paragona una moderna scuola pubblica alla scuola di grammatica di Shakespeare. Immaginate di dover costringere gli studenti del XXI secolo – dagli otto ai quindici anni! – a completare un'istruzione del genere. In effetti, quanti studenti universitari potrebbero sopravvivere? Come sottolinea l'autore del brano sopra citato, il Dr. Stanley Wells, "un ragazzo istruito in una scuola di grammatica elisabettiana avrebbe una preparazione più approfondita in retorica classica e letteratura romana (se non greca) rispetto alla maggior parte degli attuali laureati in discipline classiche".
Devo essere onesto: quello che Shakespeare ha fatto al liceo è ben oltre il mio livello di interesse per il latino. Non ho alcuna voglia di leggere Terenzio o Plauto in lingua originale e mi addormenterei molto prima di completare una declamazione latina. Credo di non essere quel tipo di "intellettuale". Sono cresciuto nel sud della California, vicino alla spiaggia, dove i compiti competevano con l'importanza fondamentale di fare una bella sessione di surf prima del tramonto, e non ho mai perso la tendenza a divertirmi – cantando, ballando, costruendo pagliai, eccetera – quando probabilmente dovrei leggere i classici. Quando si tratta della sacra liturgia, tuttavia, il mio stato d'animo è molto diverso. Per me, la Messa tradizionale è il latino al suo meglio, e comprendere i testi liturgici direttamente, invece che attraverso le traduzioni, è nella mia vita una potente fonte di gioia interiore e di ricchezza spirituale.
Non so se questo mi renda una specie di barbaro, ma preferisco i Vangeli della Vulgata e un introito latino cantato alle Odi di Orazio in qualsiasi giorno della settimana, e in qualsiasi settimana della mia vita. Fortunatamente – e questo punto non viene sufficientemente sottolineato nel mondo cattolico – imparare il latino a sufficienza per comprendere e apprezzare alcune parti della Messa (e dell'ufficio divino) è più facile che completare una tipica sequenza di corsi di latino, e molto più facile che acquisire la competenza necessaria per leggere la letteratura classica.
Il canto gregoriano, di per sé un'esperienza liturgica che cambia la vita, è inseparabile dalla lingua latina. I monaci di Solesmes, nell'introduzione al Liber Usualis, lo affermarono bene: "Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che il canto gregoriano è musica vocale latina, perché questa è la chiave per comprendere la sua struttura ritmica e melodica. È stato innestato e scaturisce dal ritmo e dalla melodia naturali delle parole, delle frasi, delle sezioni e dei periodi latini per i quali è stato scritto".
Tra l'entusiasmo per l'istruzione "classica" e la crescente popolarità della Messa tradizionale, la lingua latina riceve oggi molta attenzione, e questo è un aspetto positivo. Tuttavia, sembra esserci una scarsa consapevolezza di quanto il latino possa cambiare da un contesto all'altro. Più specificamente, si potrebbe avere l'impressione che studiare il latino medievale della liturgia cattolica sia più o meno lo stesso compito di studiare il latino letterario dell'antica Roma. Per me è chiaro che non è così, in primo luogo perché alterno continuamente tra questi due tipi di latino, e forse anche perché la mia percezione non è influenzata dalla competenza di prim'ordine che avrebbe un latinista professionista.
È stato affascinante vedere la mia valutazione confermata dal Dott. Geoffrey Hull, che, in quanto studioso di linguistica storica, è più qualificato di me per parlare di questo argomento. Le seguenti citazioni, tratte dal suo eccellente libro "The Banished Heart", sono le migliori parole che abbia mai letto su questo argomento; il corsivo è mio.
In ogni caso, la moderna caricatura del latino medievale come lingua di casta del clero istruito, un idioma completamente estraneo alla vita dei laici analfabeti, è un termine che lo storico culturale rifiuterebbe. La "morte" del latino non fu consumata fino all'inizio dell'età moderna... La conoscenza e l'uso del latino continuarono a fianco delle emergenti lingue romanze come mezzo di apprendimento e di comunicazione internazionale, nonché di culto pubblico.
Questo è più pertinente alla discussione di domenica : nell'Occidente medievale, il latino era, in una certa misura, una lingua del popolo, proprio come la liturgia latina era un tesoro non solo per il clero e gli studiosi, ma anche per i comuni laici, uomini e donne.
Grazie al suo diffuso utilizzo da parte di persone di ogni livello di istruzione, il latino medievale si liberò dai vincoli dell'idioma artificiale e castigato degli antichi autori romani e fu nutrito e arricchito dalle lingue madri dei cristiani che lo usavano.
Questo è fondamentale! Qui, Hull trasmette qualcosa che avevo intuito ma che non avevo mai espresso così chiaramente: rispetto al latino classico, il latino medievale assomiglia di più alle lingue moderne che voi ed io già conosciamo. Di conseguenza, la comprensione fluisce più naturalmente. Ciò che Hull descrive è perfettamente in sintonia con la sicurezza di sé, la temperanza intellettuale e la nozione equilibrata di tradizione dei cristiani medievali. Non erano ossessionati dal latino "corretto" o "elegante" della Roma pagana: il latino era ormai la loro lingua – la lingua della cristianità occidentale – e adottò naturalmente alcune delle caratteristiche e delle abitudini delle lingue volgari a cui era felicemente legato.
La semplificazione e l'amplificazione del latino classico da parte della cultura cattolica furono attività lodevoli secondo Sant'Agostino … ma rappresentarono una degenerazione barbara non solo per Erasmo e i suoi contemporanei del Rinascimento, ma anche per i gesuiti che dominarono l'istruzione superiore cattolica dopo il Concilio di Trento.
Con il loro ethos parzialmente modernizzato e la loro esagerata ammirazione per l'antichità pagana, gli umanisti del Rinascimento e gli ecclesiastici della Controriforma stavano creando una frattura tra i laici e la lingua latina, così come era stata plasmata dalla cristianità medievale.
Nell'insegnamento della lingua, i maestri della Compagnia di Gesù misero da parte le opere degli autori medievali scritte in un latino facile e accessibile e imposero ai loro allievi lo studio estenuante... delle gemme della letteratura pagana romana.
Molte cose belle del Medioevo sono estinte, o quasi. Ma il latino medievale, grazie a Dio, è sopravvissuto. È lì ad aspettarci, nella tradizionale liturgia romana.
Con questa idea di "Learning Liturgical Latin" mi sono posto un compito arduo: i lettori potrebbero provenire da venti diverse lingue, avere un'ampia gamma di conoscenze latine o linguistiche e avere obiettivi di comprensione diversi. Faremo il possibile e speriamo di trovare un modo per rendere questo libro utile ed efficace per la maggior parte di coloro che seguono la serie.
Concluderò il post di oggi con alcune informazioni di base e indicazioni per chiunque voglia comprendere il latino della liturgia romana.
- La Messa è un intreccio di testi di diverso tipo e quindi di stili linguistici diversi. Alcuni sono più facili da comprendere di altri. I testi propri cantati (l'Introito, la Comunione, ecc.) e le letture del Vangelo sono piuttosto accessibili. Le letture dell'Epistola tendono a essere più difficili, e preghiere come la Colletta o la Secreta possono essere piuttosto impegnative. Concentratevi sulle parti più facili e non scoraggiatevi.
- L'ufficio divino presenta uno stile meno variabile. Se siete abbastanza fortunati da assistere all'ufficio tradizionale, la maggior parte di ciò che sentirete è il latino della Bibbia Vulgata. Il salterio della Vulgata offre un buon esercizio di comprensione per gli studenti di latino: in effetti, moltissimi cristiani medievali iniziarono la loro formazione formale con i salmi latini!
- Non aspettatevi che la conoscenza del latino elimini la necessità di un messale. Anzi, potrebbe aumentarne la necessità. Una Messa tipica include vari elementi – acustica echeggiante, pronuncia scadente, bambini che piangono – che possono rendere difficile la comprensione uditiva. Un tipico messale bilingue è di grande aiuto, poiché permette di leggere le parole latine così come le si sentono. La presenza di traduzioni è utile purché funzionino come supplemento, piuttosto che come sostituzione, dei testi latini. Mi piace portare il mio Liber Usualis a Messa, anche quando non canto nel coro: non ha traduzioni in inglese, ma riesco a seguire le parole delle preghiere o delle letture, e riesco a seguire le parole e la musica dei canti propri.
Il Dott. Hull afferma che l'approccio post-medievale all'educazione "ha trasformato lo studio del latino in un'attività accademica esoterica". Questo è profondamente deplorevole. La lingua latina, così come esiste nella liturgia cattolica tradizionale, fa parte del patrimonio culturale e spirituale universale dell'Occidente: è giunto il momento di rivendicarla come tale.
Robert Keim________________________________
1 Stanley Wells, Introduzione generale a William Shakespeare: The Complete Works. Oxford University Press (2005), p. xvi.

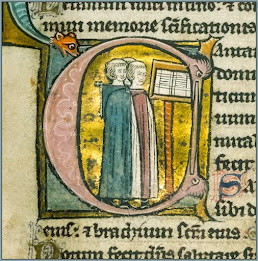


3 commenti:
Ci sono eventi che passano inosservati, eppure dicono più di tante dichiarazioni solenni. Nei giorni scorsi, UCCR ha rilanciato una notizia proveniente dagli Stati Uniti: lo scioglimento definitivo dell’associazione “Corpus”, il più antico gruppo di cattolici progressisti, fondato da sacerdoti sposati nel 1974 per promuovere la revisione del celibato, l’ordinazione delle donne, la democratizzazione della Chiesa. Dopo cinquant’anni di esistenza, si chiude con una frase amaramente rivelatrice: “Non c’è più nessuno”. Non c’è stata persecuzione. Non c’è stato anatema. È bastato il tempo. La proposta si è sciolta da sola, come neve al sole, senza lasciare dietro di sé né frutti né eredi.
Il progressismo degli anni ’70 sognava una Chiesa senza dogmi, senza disciplina, senza gerarchia. Proponeva una liberazione da tutto ciò che era “struttura”: celibato, liturgia, sacerdozio gerarchico, dottrina morale. Voleva emancipare il Vangelo dalle sue forme storiche. Ma a forza di sciogliere, ha finito per sciogliersi. E la notizia dello scioglimento di “Corpus” è simbolo di una sconfitta culturale: non c’è futuro senza radici, non c’è Chiesa senza forma, non c’è verità senza dottrina. Ora quel movimento non c’è più. È rimasto solo il silenzio. E una lezione per chi vuole ascoltarla.
Bello,bello,bello,bello. Grazie
Una bella notizia, ma non sarei così ottimista. Qui da noi la CEI spinge i vescovi affinché riuniscano più parrocchie nelle odiose "comunità pastorali", dove più preti concelebrano la mattina in una delle Chiese e nelle altre mandano i diaconi permanentati, a fare liturgia della parola più distribuzione dell'Eucarestia alle quattro vecchie che non si possono spostare perché non guidano e che, anche se protestano, sono facilmente ignorabili.
Tutto in funzione della scomparsa del clero, cosi come lo abbiamo conosciuto fino ad ora. E nel futuro?
Liturgie pseudo-eucaristiche presiedute a turno da un laico o, ancora meglio, da una laica oppure, non plus ultra, da una coppia LGBT, vera icona dell'amore sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, come qualche vescovo buontempone ha osato sacrilegamente scrivere...
Auguroni !
Posta un commento